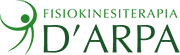Fisioterapia
Cos’è l’algodistrofia? Cause, sintomi e trattamenti
Tempo di lettura stimato 6 min.
L’algodistrofia, conosciuta anche come Sindrome Dolorosa Regionale Complessa (SDRC), è una condizione cronica e, spesso, debilitante che colpisce tipicamente un arto dopo un trauma, un intervento chirurgico o, in alcuni casi, senza una causa apparente. Si tratta di una sindrome complessa che coinvolge il sistema nervoso, il sistema immunitario e il sistema vascolare, portando a un dolore intenso e sproporzionato rispetto all’evento iniziale, accompagnato da alterazioni motorie, sensitive e trofiche, con cambiamenti nella pelle, nei capelli, nelle unghie e nelle ossa.
Riconoscere tempestivamente questa patologia e comprenderne le dinamiche è fondamentale per un trattamento efficace e per migliorare la prognosi, evitando una progressione che può portare a disabilità significative.
Quali sono le cause dell’algodistrofia?
La causa esatta dell’algodistrofia è, ancora oggi, ignota; tuttavia, si ritiene derivi da una disfunzione del sistema nervoso centrale e periferico, spesso scatenata da un evento lesivo che provoca un’alterazione nella elaborazione degli stimoli dolorosi.
Nella maggior parte dei casi, quindi, l’algodistrofia si manifesta dopo un evento scatenante, inclusi:
- traumi, come fratture ossee (anche lievi), distorsioni, lussazioni, contusioni severe;
- interventi chirurgici, come operazioni ortopediche o altri interventi che coinvolgono l’arto;
- lesioni nervose minori;
- immobilizzazione prolungata, ad esempio a causa di un gesso;
- ictus o infarto miocardico;
- infezioni.
Più raramente, l’algodistrofia può svilupparsi spontaneamente, senza una causa apparente o un evento scatenante identificabile.
Quali sono i sintomi dell’algodistrofia?
L’algodistrofia si manifesta con sintomi diversi, che possono variare in intensità e combinazione e possono essere raggruppati in quattro categorie principali:
- dolore intenso e persistente: il sintomo più caratteristico e invalidante. Il dolore è spesso descritto come bruciante, lancinante o pulsante e si presenta in modo sproporzionato rispetto al trauma iniziale. Si estende oltre la zona della lesione originale e può essere evocato anche da stimoli lievi o essere eccessivo rispetto a uno stimolo doloroso normale. Il dolore è spesso aggravato dal movimento, dal contatto o dai cambiamenti di temperatura;
- alterazioni vasomotorie e della temperatura: l’arto colpito può presentare cambiamenti significativi di temperatura e colore, quindi può essere caldo, rosso e sudato, oppure freddo, cianotico e umido;
- edema e alterazioni trofiche: si verifica un gonfiore persistente nell’arto colpito, che può essere duro e doloroso. Col tempo, la pelle può diventare lucida, tesa e sottile, assumendo un aspetto atrofico e si possono notare anche cambiamenti nella crescita dei peli (possono diradarsi o crescere più velocemente) e delle unghie (possono diventare fragili, screpolarsi o presentare alterazioni nella crescita);
- alterazioni motorie e della sensibilità: la mobilità dell’arto colpito è spesso ridotta a causa del dolore, della rigidità articolare e dell’edema. Si possono sviluppare debolezza muscolare, tremori, spasmi o difficoltà nel coordinare i movimenti e, in alcuni casi, possono comparire anche alterazioni della sensibilità, come una sensazione di “”spilli e aghi”” o intorpidimento.
L’algodistrofia può evolvere anche molto rapidamente, nell’arco di alcuni mesi; proprio per questo, la diagnosi precoce è indispensabile per prevenire queste evoluzioni più gravi e, di conseguenza, il peggioramento della qualità della vita del paziente.
Come si diagnostica l’algodistrofia?
La diagnosi di algodistrofia può essere complessa e richiede un’attenta valutazione clinica. Il processo diagnostico inizia con l’anamnesi approfondita, in cui il medico raccoglie informazioni dettagliate sull’esordio del dolore, sulla sua intensità e qualità, sull’evento scatenante (se presente) e sull’evoluzione dei sintomi nel tempo. Si indaga anche sulla presenza di altri disturbi o patologie.
Successivamente, si esegue un esame obiettivo accurato dell’arto interessato e del paziente nel suo complesso; nello specifico, il medico indaga:
- il dolore, tipo e localizzazione, presenza di allodinia (dolore al contatto leggero) o iperalgesia (risposta esagerata a stimoli dolorosi);
- le alterazioni sensoriali, come ipoestesia (ridotta sensibilità) o disestesia (sensazione anomala);
- le alterazioni vasomotorie, come variazioni di temperatura (caldo/freddo) e colore (rossore/cianosi) della pelle tra l’arto affetto e quello sano;
- eventuali edema e alterazioni trofiche, cioè gonfiore e modifiche della pelle (lucida, sottile), dei peli (crescita o perdita) e delle unghie (fragilità, striature).
- le alterazioni motorie, come riduzione del movimento, rigidità articolare, debolezza muscolare, tremori.
Per supportare la diagnosi e, soprattutto, per escludere altre patologie, possono essere eseguiti ulteriori esami strumentali:
- scintigrafia ossea trifasica, l’esame strumentale più specifico e spesso utilizzato per l’algodistrofia, che mostra un aumento dell’attività metabolica ossea nella fase tardiva, caratteristica della condizione;
- radiografie, che possono mostrare un’osteopenia (riduzione della densità ossea) maculata o diffusa nella fase avanzata della malattia;
- risonanza magnetica (RM), utile per escludere altre cause di dolore, come lesioni ai tessuti molli, ernie discali o infezioni;
- esami del sangue, per escludere altre condizioni infiammatorie, infettive o reumatiche che potrebbero mimare i sintomi;
- test di conduzione nervosa/elettromiografia, utili per escludere neuropatie o altre condizioni neurologiche che potrebbero essere la causa dei sintomi.
La diagnosi di algodistrofia è clinica e si basa sui Criteri di Budapest, che richiedono la presenza di sintomi in diverse categorie e segni obiettivi specifici, in aggiunta all’esclusione di altre diagnosi che potrebbero spiegare meglio il quadro clinico. La precocità della diagnosi, così come sottolineato dai professionisti di Fisioterapia D’Arpa di Palermo, è fondamentale per iniziare tempestivamente il trattamento e migliorare la prognosi.
Come si cura l’algodistrofia?
La cura dell’algodistrofia è complessa e richiede un approccio multidisciplinare per massimizzare le possibilità di successo e prevenire la cronicizzazione e le disabilità. Il trattamento può includere diverse strategie, in primis la farmacoterapia a base di farmaci per gestire il dolore e modulare la risposta del sistema nervoso e immunitario. Possono essere impiegati:
- antidolorifici, dai FANS agli oppioidi, a seconda dell’intensità del dolore;
- corticosteroidi, utili per ridurre l’infiammazione e l’edema, soprattutto nelle fasi iniziali;
- bisfosfonati, che possono ridurre l’edema osseo e il dolore, spesso somministrati per via endovenosa.
- neuromodulatori, antidepressivi triciclici o farmaci antiepilettici efficaci per il dolore neuropatico.
Nel trattamento dell’algodistrofia, la fisioterapia è a dir poco indispensabile e insostituibile. L’intervento riabilitativo deve essere intrapreso il prima possibile e condotto con estrema cautela, proprio per non aumentare il dolore ma, al contempo, per favorire il recupero funzionale. Gli obiettivi principali della fisioterapia sono:
- il controllo del dolore, attraverso tecniche delicate e non aggressive;
- la riduzione dell’edema, per migliorare la mobilità e il comfort;
- il miglioramento della mobilità articolare, per prevenire e ridurre la rigidità;
- il recupero della forza e della coordinazione, per ripristinare la funzionalità dell’arto;
- la normalizzazione della percezione sensoriale, per ridurre allodinia e iperalgesia.
Tra le tecniche fisioterapiche più utilizzate dai professionisti di Fisioterapia D’Arpa di Palermo rientrano:
- la terapia manuale delicata, con mobilizzazioni articolari passive o attive-assistite e massaggi per un rilassamento muscolare e per contrastare la rigidità articolare;
- l’esercizio terapeutico graduale, a base di esercizi a bassa intensità, con progressione lentissima;
- la desensibilizzazione sensoriale, con tecniche per aiutare il sistema nervoso a rielaborare correttamente gli stimoli;
- le terapie fisiche strumentali, che possono essere utilizzate per il controllo del dolore e dell’infiammazione, come la tecarterapia, il laser ad alta potenza e la TENS, o la Magnetoterapia e la SIS per la riduzione dell’edema osseo.
Data la natura del dolore cronico e l’impatto sulla qualità di vita, il supporto psicologico o psicoterapeutico può essere molto utile per gestire l’ansia, la depressione e la paura del movimento che, spesso, accompagnano l’algodistrofia.
La collaborazione tra medico, fisioterapista e altri specialisti (come psicologi o anestesisti del dolore) è essenziale per un trattamento integrato e per offrire al paziente le migliori possibilità di recupero.
Articoli correlati