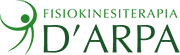Fisioterapia
Spondilite anchilosante: cause, sintomi e trattamenti
Tempo di lettura stimato 6,8 min.
La spondilite anchilosante è una malattia infiammatoria cronica e sistemica che colpisce principalmente lo scheletro assiale, cioè la colonna vertebrale e le articolazioni sacroiliache. Nonostante la sua natura progressiva possa portare a una rigidità significativa e a una perdita di funzionalità, non si tratta di una condanna. Per molti anni, la spondilite è stata una patologia spesso diagnosticata in ritardo, data la sua somiglianza iniziale con un comune mal di schiena; tuttavia, una maggiore consapevolezza clinica e l’avanzamento delle tecniche diagnostiche e terapeutiche hanno rivoluzionato la sua gestione.
Oggi, grazie a un approccio multidisciplinare che unisce la terapia farmacologica a una fisioterapia mirata, è possibile non solo controllare i sintomi e rallentare la progressione della malattia, ma anche mantenere una qualità della vita elevata e una mobilità soddisfacente per molti anni. E i professionisti di Fisioterapia D’Arpa di Palermo sono a completa disposizione per aiutare i pazienti affetti a ritrovare il proprio benessere.
Cos’è la spondilite anchilosante?
La spondilite anchilosante rientra nel gruppo delle spondiloartriti, patologie autoimmuni caratterizzate da un’infiammazione persistente che colpisce l’organismo. La sua peculiarità sta nel prevalente coinvolgimento delle articolazioni, in particolare quelle che si trovano tra le vertebre e quelle sacroiliache, che connettono l’osso sacro al bacino. L’infiammazione cronica, con il passare del tempo, provoca una graduale calcificazione e una fibrosi dei legamenti e dei dischi intervertebrali, portando a una condizione nota come anchilosi; in pratica, le vertebre tendono a fondersi tra loro, compromettendo la mobilità della colonna vertebrale e portando a una postura curva, chiamata “schiena a punto interrogativo” o, nelle fasi più avanzate, “dorso a canna di bambù”.
La malattia non si limita, però, solo alla colonna: l’infiammazione può colpire anche le articolazioni periferiche, come quelle dell’anca, delle spalle, delle ginocchia e dei piedi. In alcuni casi, può interessare anche altri organi o apparati, come gli occhi (con uveite o irite), l’intestino (con patologie infiammatorie croniche) o il cuore.
È una malattia che, pur non essendo fatale, può avere un impatto significativo sulla vita quotidiana, ma un’attenta gestione clinica e terapeutica può mitigare notevolmente le sue conseguenze.
Quali sono le cause della spondilite anchilosante?
Le cause esatte della spondilite anchilosante non sono ancora del tutto chiare e rappresentano un’area di ricerca attiva; tuttavia, è ampiamente riconosciuto che la malattia ha una forte componente genetica. Il principale fattore di rischio genetico è la presenza del gene HLA-B27: circa il 90-95% delle persone con spondilite anchilosante è positiva a questo marcatore genetico, rispetto a circa l’8% della popolazione generale. Nonostante questa correlazione, è importante sottolineare che il gene HLA-B27 non è una condanna, anzi: la maggior parte delle persone che lo possiedono non svilupperà mai la malattia. Questo suggerisce che, oltre alla predisposizione genetica, debbano esserci altri fattori che contribuiscono a scatenare la patologia.
Si ritiene che fattori ambientali, come specifiche infezioni batteriche a carico dell’apparato gastrointestinale, possano agire come “grilletto” per l’attivazione del sistema immunitario in un individuo geneticamente predisposto. Un’infezione potrebbe innescare una reazione immunitaria che, per un meccanismo di mimetismo molecolare, attacca per errore i tessuti connettivi delle articolazioni, avviando il processo infiammatorio cronico. La malattia si manifesta più comunemente in età giovanile, con un esordio tipico tra i 15 e i 30 anni, e colpisce gli uomini con una frequenza circa tre volte superiore rispetto alle donne.
I sintomi principali
I sintomi della spondilite anchilosante sono spesso subdoli e possono evolvere gradualmente, rendendo difficile la diagnosi precoce. I sintomi più comuni e distintivi sono un dolore cronico e una rigidità nella parte bassa della schiena e nelle natiche. Il dolore, nello specifico, ha delle caratteristiche peculiari:
- è di tipo infiammatorio: il dolore tende a migliorare con l’attività fisica e a peggiorare con il riposo e l’inattività, in particolare al mattino. Un comune mal di schiena, invece, di solito peggiora con il movimento;
- è intenso al mattino: la rigidità mattutina è un sintomo quasi sempre presente e può durare per ore, rendendo difficile alzarsi dal letto;
- è bilaterale: il dolore si manifesta spesso su entrambi i lati del corpo, in particolare a livello delle articolazioni sacroiliache.
Oltre al dolore e alla rigidità, altri sintomi che possono manifestarsi includono:
- dolore al torace: l’infiammazione delle articolazioni tra le costole e lo sterno può causare un dolore che si acutizza con la tosse profonda o con la respirazione;
- dolore alle articolazioni periferiche: l’infiammazione può interessare le ginocchia, le caviglie, le spalle e le anche, causando gonfiore, dolore e rigidità;
- entesite: l’infiammazione delle entesi, ovvero i punti in cui tendini e legamenti si attaccano all’osso, è un sintomo caratteristico e causa dolore in punti specifici come il tallone (tendine d’Achille), la pianta del piede, i gomiti o la parte posteriore del ginocchio;
- affaticamento: la stanchezza cronica è un sintomo molto comune, legato al consumo energetico costante del corpo per combattere l’infiammazione.
Nonostante la varietà dei sintomi, è fondamentale che il paziente e il medico non li sottovalutino. Una diagnosi precoce è essenziale per poter intervenire in modo tempestivo, prevenire la rigidità progressiva e mantenere un’ottima qualità della vita.
Spondilite anchilosante e diagnosi
Il percorso diagnostico della spondilite anchilosante può essere lungo e complesso, in quanto i sintomi iniziali possono essere facilmente confusi con altre condizioni muscolo-scheletriche. È fondamentale, quindi, rivolgersi a un medico reumatologo, che è la figura di riferimento per questo tipo di patologie e inizia la diagnosi con anamnesi ed esame fisico: raccoglie la storia clinica del paziente, valuta i sintomi e misura la mobilità della colonna vertebrale e la capacità di espansione del torace. Seguono gli esami del sangue: un prelievo ematico può rilevare la presenza di marcatori infiammatori, come la proteina C-reattiva (PCR) e la velocità di eritrosedimentazione (VES), che risultano aumentati. Si ricerca, inoltre, la presenza del gene HLA-B27. Infine, si eseguono le radiografie, in particolare la risonanza magnetica: le prime possono mostrare le alterazioni iniziali a livello delle articolazioni sacroiliache, mentre la risonanza magnetica è molto più sensibile nell’individuare l’infiammazione precoce, anche prima che si manifestino i danni strutturali visibili con la radiografia.
Un ritardo nella diagnosi può portare a un ritardo nell’inizio del trattamento, permettendo alla malattia di progredire e di causare danni irreversibili. Per questo motivo, la sensibilizzazione sui sintomi è di estrema importanza.
I migliori trattamenti
Il trattamento della spondilite anchilosante è un percorso multidisciplinare che non si limita solo alla terapia farmacologica, ma si basa su un approccio integrato che include anche un ruolo centrale per la fisioterapia. I farmaci, come gli antinfiammatori non steroidei (FANS) e i più recenti farmaci biologici, sono fondamentali per tenere sotto controllo l’infiammazione e il dolore, ma da soli non sono sufficienti a prevenire la rigidità e la perdita di mobilità.
La fisioterapia non è un’opzione, ma una componente essenziale del trattamento. Il suo obiettivo primario è contrastare la rigidità, mantenere la funzionalità delle articolazioni e della colonna vertebrale e migliorare la postura. Un fisioterapista specializzato in patologie reumatiche può elaborare un piano di trattamento personalizzato che include diversi tipi di esercizi.
Gli esercizi di mobilità e stretching sono fondamentali per mantenere la flessibilità della colonna e delle anche e prevenire la fusione delle vertebre; gli esercizi di rinforzo, invece, mirati ai muscoli del tronco (addominali e paravertebrali), sono altrettanto importanti per stabilizzare la colonna vertebrale e sostenere il corpo, migliorando l’equilibrio e riducendo il rischio di cadute; infine, gli esercizi posturali e la rieducazione funzionale aiutano il paziente a mantenere una postura corretta e a svolgere le attività quotidiane in modo più efficiente, prevenendo le deformità.
Inoltre, i fisioterapisti impiegano anche tecniche di terapia manuale per alleviare il dolore e le tensioni muscolari e consigliano attività come il nuoto, particolarmente benefico in quanto l’acqua sostiene il corpo e riduce il carico sulle articolazioni.
La combinazione di un programma di esercizi regolare, personalizzato e supervisionato, con la terapia farmacologica, è la strategia migliore per rallentare la progressione della malattia e mantenere una vita attiva e soddisfacente.
La spondilite anchilosante è una condizione complessa, ma con la giusta diagnosi e un trattamento tempestivo e completo, è possibile gestirne i sintomi, rallentarne la progressione e mantenere un’ottima qualità della vita. La fisioterapia rappresenta un pilastro fondamentale di questo trattamento, non solo per alleviare il dolore e la rigidità, ma per restituire al paziente la libertà di movimento, l’autonomia e la fiducia nel proprio corpo che la malattia tende a sottrarre. L’obiettivo non è solo curare, ma permettere a chi ne soffre di vivere pienamente, superando gli ostacoli che la malattia presenta.
Articoli correlati