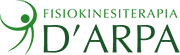Fisioterapia
Sindrome miofasciale: come riconoscerla e trattarla con la fisioterapia
Tempo di lettura stimato 5,4 min.
Indice Articolo
La sindrome miofasciale è una condizione dolorosa comune, spesso sottovalutata, che colpisce muscoli e fascia, cioè il tessuto connettivo che li avvolge. Si manifesta attraverso punti particolarmente sensibili e contratti all’interno del muscolo, noti come “trigger point”, che possono scatenare dolore sia localizzato che irradiato in altre aree del corpo. Questo disturbo può limitare gravemente la mobilità, influenzare il sonno e ridurre la qualità della vita, rendendo difficili anche le attività quotidiane più semplici.
Riconoscere i suoi sintomi e comprendere come la fisioterapia possa essere fondamentale nel trattamento è importante per intraprendere un percorso di recupero efficace. E i professionisti di Fisioterapia D’Arpa di Palermo offrono un approccio mirato e personalizzato per gestire i sintomi e ritrovare il giusto benessere.
Quali sono le cause della sindrome miofasciale?
La sindrome miofasciale può essere scatenata da una varietà di fattori, spesso legati a un sovraccarico o a un’irritazione cronica del tessuto muscolare e fasciale.
Una delle cause principali è il trauma muscolare, sia acuto (come un colpo diretto o uno stiramento improvviso) sia, più frequentemente, dovuto a microtraumi ripetitivi o sovraccarico funzionale, che si verificano con movimenti errati, posture scorrette mantenute per lungo tempo o attività lavorative che richiedono sforzi costanti. Anche le squilibri posturali, come una gamba più corta dell’altra o la scoliosi, possono causare uno stress eccessivo su determinati gruppi muscolari, portando allo sviluppo di trigger point.
Al contempo, anche lo stress psicologico e l’ansia sono fattori significativi, in quanto inducono spesso una contrazione muscolare involontaria e prolungata, che riduce l’apporto di sangue ai muscoli e favorisce la formazione di nodi dolorosi, così come i disturbi del sonno, che impediscono un adeguato riposo muscolare e alcune carenze nutrizionali (come quelle di vitamina D, B o minerali come magnesio e potassio), che possono contribuire alla predisposizione.
I principali sintomi della sindrome miofasciale
La sindrome miofasciale si manifesta con un gran numero di sintomi che possono variare in intensità e localizzazione.
Il sintomo principale è il dolore, che può essere localizzato o, più tipicamente, irradiarsi a distanza seguendo schemi specifici, un fenomeno noto come “dolore riferito”. Questo dolore è spesso descritto come sordo, profondo e costante, ma può acutizzarsi con il movimento o la pressione sul punto trigger.
Altri due sintomi tipici sono la rigidità e la limitazione del movimento nell’articolazione vicina al muscolo colpito, poiché il muscolo contratto impedisce un’estensione completa.
La presenza di trigger point palpabili, poi, è un indicatore chiave: si tratta di noduli o “nodi” molto sensibili al tatto all’interno di una banda tesa di muscolo e la pressione su questi punti può scatenare un dolore intenso e riprodurre il dolore riferito dal paziente.
Possono manifestarsi anche debolezza o affaticamento muscolare nell’area interessata e, in alcuni casi, fenomeni come sudorazione localizzata, lacrimazione o alterazioni vascolari. Il dolore cronico può, inoltre, disturbare il sonno e avere un impatto psicologico, generando frustrazione e ansia.
Riconoscere e comprendere questi sintomi è essenziale per una corretta valutazione e per individuare la terapia più indicata.
Come si diagnostica la sindrome miofasciale
La diagnosi della sindrome miofasciale è sostanzialmente clinica e si basa su un’accurata raccolta dell’anamnesi del paziente e su un dettagliato esame fisico; non esistono, infatti, test di laboratorio o indagini strumentali specifiche, come radiografie o risonanze magnetiche, in grado di confermare direttamente la presenza dei trigger point miofasciali.
Il medico o il fisioterapista iniziano, quindi, con un’anamnesi approfondita, chiedendo al paziente di descrivere la natura del dolore, l’inizio dei sintomi, eventuali traumi pregressi, abitudini lavorative o posturali e la presenza di stress o disturbi del sonno.
Successivamente, si procede con l’esame fisico, durante il quale terapista palpa attentamente i muscoli sospetti per individuare la presenza di bande tese e, all’interno di esse, i trigger point attivi o latenti: un trigger point attivo è un punto dolente che riproduce il dolore familiare del paziente, mentre un trigger point latente è un punto dolente alla palpazione, ma che non causa dolore spontaneo o riferito se non stimolato. Vengono, inoltre, valutati il range di movimento delle articolazioni e la forza muscolare per identificare eventuali limitazioni o debolezze causate dalla contrazione muscolare.
È fondamentale che si esegua una diagnosi differenziale, in modo da escludere altre condizioni con sintomi simili, come radicolopatie (problemi nervosi della colonna), fibromialgia, artrosi o borsiti, che richiedono trattamenti diversi.
Come trattare la sindrome miofasciale
Il trattamento della sindrome miofasciale mira a disattivare i trigger point, ridurre il dolore, ripristinare la funzionalità muscolare e prevenire le recidive.
Per alleviare il dolore acuto, il medico può occasionalmente prescrivere farmaci come antinfiammatori non steroidei (FANS) per brevi periodi o miorilassanti per le contrazioni più severe. In alcuni casi, si possono considerare infiltrazioni di anestetici locali o corticosteroidi direttamente nei trigger point, per un sollievo mirato e temporaneo.
Le modifiche dello stile di vita sono altrettanto importanti: la gestione dello stress, l’adozione di una postura corretta sul posto di lavoro e il miglioramento della qualità del sonno sono passi fondamentali per ridurre i fattori scatenanti.
La fisioterapia è un vero e proprio pilastro del trattamento della sindrome miofasciale e, come accade presso Fisioterapia D’Arpa di Palermo, il percorso terapeutico è personalizzato sulle esigenze e sulle caratteristiche del paziente.
Le tecniche di terapia manuale sono al centro del trattamento: vengono utilizzate tecniche di rilascio dei trigger point, come la compressione ischemica, che applica una pressione sostenuta sul trigger point per “disattivarlo”, seguita da uno stretching mirato del muscolo. Il massaggio terapeutico e il rilascio miofasciale sono impiegati per sciogliere le aderenze fasciali e ridurre la tensione muscolare generale. Se presenti, le restrizioni articolari vengono affrontate con mobilizzazioni articolari specifiche.
Gli esercizi terapeutici sono essenziali per il recupero a lungo termine. Il fisioterapista insegna esercizi di stretching specifici per allungare i muscoli accorciati e esercizi di rinforzo per correggere gli squilibri muscolari e stabilizzare la postura. Al contempo, la rieducazione posturale è utile per insegnare al paziente come mantenere posizioni corrette durante le attività quotidiane e prevenire il sovraccarico muscolare. Possono essere integrate anche terapie fisiche strumentali come la tecarterapia o la laserterapia, per favorire il rilassamento muscolare, ridurre il dolore residuo e accelerare il processo di guarigione dei tessuti.
Infine, l’educazione del paziente è fondamentale: imparare a riconoscere i propri fattori scatenanti, adottare tecniche di auto-gestione (come l’auto-massaggio o lo stretching quotidiano) e mantenere un regime di esercizio fisico regolare sono passaggi chiave per prevenire le recidive e vivere senza dolore.
Articoli correlati