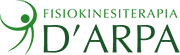Fisioterapia
Arteriopatia periferica: come alleviare i sintomi con la fisioterapia
Tempo di lettura stimato 7,2 min.
L’arteriopatia periferica consiste in una condizione in cui le arterie, cioè i vasi sanguigni che trasportano il sangue ossigenato dal cuore al resto del corpo, si restringono, riducendo così il flusso sanguigno verso gli arti sia superiori che inferiori, prediligendo questi ultimi. L’arteriopatia periferica non è solo un problema di dolore locale; è anche un segnale di allarme per la possibile presenza di malattie cardiovascolari più diffuse. Proprio per questo, comprendere le cause, i sintomi e, soprattutto, come la fisioterapia possa alleviare i disagi e migliorare la qualità di vita è fondamentale per chi ne soffre.
Quali sono le cause dell’arteriopatia periferica?
L’arteriopatia periferica è quasi sempre causata dall’aterosclerosi, un processo progressivo in cui le arterie si induriscono e si restringono a causa dell’accumulo di placche di grasso, colesterolo, calcio e altre sostanze sulle loro pareti interne. Questo accumulo, chiamato placca aterosclerotica, riduce il lume del vaso sanguigno, limitando il flusso di sangue ricco di ossigeno e nutrienti verso i tessuti e gli organi, in particolare quelli delle gambe e dei piedi.
Esistono diversi fattori di rischio che accelerano lo sviluppo dell’aterosclerosi e, di conseguenza, aumentano la probabilità di sviluppare l’arteriopatia periferica:
- il fumo, che danneggia le pareti dei vasi sanguigni e accelera l’aterosclerosi.
- il diabete, poiché alti livelli di zucchero nel sangue danneggiano le arterie, soprattutto quelle piccole;
- l’età avanzata, infatti l’aterosclerosi è più comune nelle persone con età superiore ai 50 anni;
- la pressione alta (ipertensione), che danneggia le pareti delle arterie, rendendole più vulnerabili alla formazione di placche;
- il colesterolo alto, che contribuisce direttamente alla formazione delle placche;
- l’obesità, che aumenta il rischio di arteriopatia periferica;
- l’inattività fisica, che favorisce l’insorgenza di altri fattori di rischio, come obesità, ipertensione e diabete;
- la storia familiare, quindi una predisposizione genetica può aumentare il rischio.
Più raramente, l’arteriopatia periferica può essere causata da infiammazioni dei vasi sanguigni (vasculite), lesioni ai vasi sanguigni degli arti, anomalie strutturali dei muscoli o dei legamenti, o esposizione a radiazioni. Comprendere questi fattori di rischio è essenziale non solo per la diagnosi, ma anche per la prevenzione e la gestione della malattia.
Secondo la classificazione di Fontaine si distinguono quattro stadi di arteriopatia:
- I stadio: Asintomatico
- II stadio: Claudicatio intermittens
- III stadio: Dolore a riposo
- IV stadio: Lesione trofiche e necrosi
Quali sono i principali sintomi dell’arteriopatia periferica?
I sintomi dell’arteriopatia periferica si manifestano quando il flusso sanguigno agli arti inferiori è insufficiente per soddisfare le richieste metaboliche dei muscoli, soprattutto durante l’attività.
Il sintomo più caratteristico è la claudicatio intermittens, un dolore muscolare crampiforme o una sensazione di pesantezza e affaticamento che si verifica nelle gambe durante l’esercizio fisico. Il dolore scompare tipicamente entro pochi minuti di riposo, per poi ricomparire quando l’attività riprende.
Oltre alla claudicatio, altri sintomi possono indicare la presenza di arteriopatia periferica:
- dolore alle gambe a riposo: nelle fasi più avanzate, il dolore può manifestarsi anche a riposo, spesso di notte, localizzato nei piedi o nelle dita;
- intorpidimento o debolezza: sensazione di intorpidimento, debolezza o freddo in una gamba o in un piede;
- pelle alterata: la pelle della gamba e del piede colpiti può apparire pallida o cianotica, lucida e sottile. I peli sulla gamba possono diradarsi o scomparire, mentre le unghie dei piedi possono crescere più lentamente o apparire fragili;
- ulcere e ferite che non guariscono: piccole lesioni, ferite o ulcere sui piedi o sulle dita possono impiegare molto tempo a guarire, o non guarire affatto, a causa dello scarso afflusso di sangue. Nei casi più gravi, questo può portare a infezioni e, in ultima istanza, alla gangrena e all’amputazione;
- debolezza muscolare: una ridotta forza nei muscoli della gamba interessata;
- assenza o debolezza dei polsi periferici: il medico potrebbe rilevare un polso debole o assente nelle arterie del piede o della caviglia.
È importante non sottovalutare questi sintomi e consultare immediatamente un medico, dato che l’arteriopatia periferica non solo può limitare la capacità di camminare, ma è anche un forte indicatore di un rischio aumentato di infarto e ictus.
Come si diagnostica l’arteriopatia periferica?
La diagnosi dell’arteriopatia periferica è fondamentale per prevenire complicanze gravi e impostare un trattamento efficace. Il primo passo è l’anamnesi approfondita, durante la quale il medico raccoglie informazioni sui sintomi riferiti, sui fattori di rischio cardiovascolare e sulla storia medica familiare.
Successivamente, l’esame obiettivo si concentra sugli arti inferiori: il medico valuta la temperatura della pelle, il colore, la presenza di alterazioni trofiche e la presenza di eventuali ferite che non guariscono.
Per confermare la diagnosi e valutarne la gravità, si eseguono ulteriori esami strumentali:
- indice caviglia-braccio (ABI – Ankle-Brachial Index): il test diagnostico non invasivo più comune e semplice. Consiste nel misurare la pressione sanguigna alla caviglia e al braccio utilizzando un manicotto e un Doppler. Il rapporto tra la pressione sistolica della caviglia e quella del braccio fornisce un indice: un valore di ABI inferiore a 0.9 indica la presenza di arteriopatia periferica;
- ecodoppler arterioso degli arti inferiori: permette di visualizzare direttamente il flusso sanguigno nelle arterie, identificare restringimenti (stenosi), occlusioni e valutare la velocità del flusso;
- test da sforzo su tapis roulant: se l’ABI a riposo è normale o borderline, ma i sintomi sono eloquenti, si può ripetere la misurazione dell’ABI dopo un breve esercizio fisico su tapis roulant. In caso di arteriopatia periferica, infatti, l’ABI post-esercizio diminuisce significativamente;
- angiografia (TC angiografia, RM angiografia o angiografia convenzionale): esami più invasivi che utilizzano un mezzo di contrasto per visualizzare le arterie. Vengono solitamente riservati ai casi in cui si considera un intervento chirurgico o una procedura di rivascolarizzazione (angioplastica).
La combinazione di questi strumenti diagnostici permette al medico di definire con precisione la diagnosi di arteriopatia periferica, valutare l’estensione della malattia e pianificare il trattamento più appropriato.
Quali sono i trattamenti più efficaci per l’arteriopatia periferica?
Il trattamento dell’arteriopatia periferica mira a ridurre i sintomi, migliorare la mobilità, prevenire la progressione dell’aterosclerosi e ridurre il rischio di eventi cardiovascolari gravi come infarto e ictus. Le strategie terapeutiche includono, in primo luogo, netti cambiamenti dello stile di vita:
- smettere di fumare, per rallentare la progressione dell’arteriopatia periferica;
- gestire il diabete, con un controllo rigoroso dei livelli di zucchero nel sangue.
- controllare la pressione alta e il colesterolo, attraverso dieta, esercizio fisico e, se necessario, farmaci.
- seguire una dieta sana, povera di grassi saturi, ricca di frutta, verdura e cereali integrali.
Al contempo, il medico può prescrivere farmaci specifici:
- statine, per ridurre il colesterolo;
- antipertensivi, per controllare la pressione sanguigna;
- ipoglicemizzanti, per controllare il diabete;
- antiaggreganti piastrinici, per prevenire la formazione di coaguli;
In casi di arteriopatia periferica grave o invalidante o quando le terapie conservative non sono sufficienti, possono essere considerate procedure chirurgiche per ripristinare il flusso sanguigno:
- angioplastica con o senza stent, che prevede l’inserimento di un piccolo palloncino nell’arteria ristretta per dilatarla, a volte lasciando uno stent per mantenerla aperta.
- bypass chirurgico, con il quale si crea un nuovo percorso per il sangue utilizzando un vaso sanguigno sano (preso dal paziente stesso o sintetico) per bypassare l’arteria bloccata.
Da non sottovalutare, poi, la fisioterapia e l’esercizio terapeutico strutturato, due componenti fondamentali e di comprovata efficacia nel trattamento dell’arteriopatia periferica, in particolare per migliorare la claudicatio intermittens e la qualità di vita. La riabilitazione vascolare, condotta sotto la supervisione di fisioterapisti esperti come i professionisti di Fisioterapia D’Arpa di Palermo, è spesso la più efficace terapia non farmacologica per i sintomi da sforzo.
L’obiettivo principale è di migliorare la distanza di cammino senza dolore e la qualità di vita complessiva del paziente attraverso un programma di cammino supervisionato, che prevede:
- cammino intervallato: il paziente cammina fino a quando il dolore della claudicatio non si manifesta in modo significativo, poi si ferma per riposare fino alla scomparsa del dolore, per poi riprendere a camminare. Questo approccio non solo migliora la tolleranza al dolore, ma stimola anche la formazione di nuovi piccoli vasi sanguigni (circoli collaterali) che possono bypassare le occlusioni, aumentando l’afflusso di sangue ai muscoli;
- aumento graduale dell’intensità e della durata: con il tempo, il fisioterapista aumenta progressivamente la distanza di cammino, la velocità o la durata delle sessioni;
- esercizi di rinforzo e flessibilità: possono migliorare la forza muscolare generale degli arti inferiori e la mobilità articolare, contribuendo a una deambulazione più efficiente e meno dolorosa.
Il programma di esercizio per l’arteriopatia periferica richiede costanza e impegno da parte del paziente, ma i benefici sono notevoli: un aumento della distanza di cammino senza dolore, un miglioramento della qualità di vita e una riduzione del rischio di progressione della malattia. La fisioterapia, quindi, così come proposta dai professionisti dell’Ambulatorio D’Arpa di Palermo, non si limita a trattare il sintomo, ma contribuisce attivamente al miglioramento della funzionalità vascolare e del benessere generale del paziente con arteriopatia periferica.
Articoli correlati